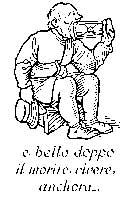Nel 1989 Loescher Editore viene acquisita da un’altra grande casa editrice italiana, la Zanichelli di Bologna, ma mantiene una propria struttura in tutto autonoma.
Dal 1989 la Casa editrice, pur conservando alcune riviste (anzi nel 1990 viene fondato «L’asino d’oro», una nuova rivista di analisi, interpretazione e discussione della letteratura [italiana e straniera], diretta da Francesco Brioschi, Remo Ceserani, Lidia De Federicis, Costanzo Di Girolamo, Giulio Ferroni, Franco Marenco, Giuseppe Sertoli), ha rivolto il suo interesse in modo quasi esclusivo alla lessicografia e alla produzione scolastica per la scuola media inferiore e superiore.
Nel 1991 esce la Storia della letteratura greca e nel 1992 le Pagine di letteratura greca di Giovanni Tarditi. Si tratta di opere che, aggiornate sulla base delle più recenti acquisizioni storico-filologiche consentivano di trarre nuove prospettive dal contatto diretto con i testi.
Esce anche la terza edizione de La ricerca filosofica di Gabriele Giannantoni (1992), un manuale fra i più conosciuti nella nostra scuola. Tra le sue caratteristiche ritroviamo quella dei “corsi integrati”, con l’inserimento di numerosi brani di molti autori dentro i rispettivi contesti, secondo il filone ormai consolidato in Loescher di presentare i profili teorici accanto ai brani antologici.
E a proposito di corsi integrati, nel 1992 Giovanna Barbieri, autrice storica della Casa editrice fin dalla metà degli anni ’60 (la sua opera più recente è uscita nel 2008) pubblica con Loescher la quarta edizione del Corso di lingua latina. Si tratta di un manuale rivoluzionario che riscuote un grande apprezzamento, perché rappresenta la reale alternativa alle grammatiche normative e nozionistiche fino a quel momento dominanti: si presentano in forma semplificata le regole del latino insieme alla parte degli esercizi, in modo funzionale al lavoro di traduzione. Alla struttura integrata di questa opera si rifarà tutta la produzione italiana di corsi di latino degli anni ’2000.
Dopo il successo avuto con Il materiale e l’immaginario, la Loescher ha pubblicato altre valide antologie per il biennio della scuola superiore, come Lavori in corso (1995), di Ferdinando Cozzi e Luciana Virno, e Il viaggiatore senza bagaglio (1998) di Nerella Botta, seguito da Il lettore nella rete (2001), opera della stessa autrice, coadiuvata da Lidia Cardi, Lucia Enrini, Valerio Natoli, Rosaria Prudente ed Elena Tornaghi.
Ricca e curata è risultata innanzitutto la produzione relativa all’educazione linguistica, sia per l’italiano sia per le lingue classiche e moderne.
Sono stati accolti con favore, nei bienni della scuola superiore, L’uso e le regole dell’italiano (1994), Italiano: l’uso e la grammatica (1996) e Strumenti per l’italiano(prima edizione nel 2000, seconda edizione nel 2004), tutti di Silvia Fogliato e Maria Carla Testa.
Loescher Editore ha investito nuove risorse nella produzione destinata alla scuola secondaria di primo grado / scuola media inferiore dando vita a corsi molto apprezzati dai docenti. Il successo dell’antologia Trovare le parole, di Tiziano Franzi, Federico Pedullà e Marina Pasini (prima edizione nel 1997; successive nel 2001 e nel 2004, con l’ingresso tra gli autori di Simonetta Damele) è seguito da quello de Il colibrì nel 2006. Nel 2004 intanto esce un’antologia di italiano per il biennio Voltare pagina di Simonetta Damele e Tiziano Franzi. Le antologie di questo gruppo di autori si contraddistinguono per essere state le prime a introdurre il discorso su metodo, abilità e lavoro per competenze.
In parallelo riscontra un alto gradimento anche il corso di grammatica A chiare lettere di Anna Palazzo e Marina Ghilardi (edizioni nel 2001, 2004; edizione in due volumi nel 2006) e il successivo corso Grammatica. Le regole e le parole per comunicare (2007) alla stesura del quale collaborano Anna Palazzo, Adele Arciello e Antonio Maiorano. Affianca questo corso la Grammatica semplificata per stranieri, che si inserisce all’interno di un progetto più ampio destinato allo studio dell’italiano come seconda lingua sia da parte dei giovani che degli adulti con opere quali Contatto e Viaggio nell’italiano di Rosella Bozzone Costa, il primo corso di italiano per stranieri pubblicato da un editore di scolastica in Italia.
Particolarmente significativa è risultata la produzione nel settore delle lingue straniere con validi corsi di lingua sia per quanto riguarda l’inglese e il francese, sia per il tedesco e, più recentemente, per lo spagnolo.
Per l’INGLESE si segnalano:
— Frames e New Frames, di Paola Pace, Maria Carla Pavoni, Graziella Pozzo, Tim Priesack (1992), un corso di inglese articolato in quadri di riferimento che legano in modo organico testi e attività, mirato sugli interessi e le motivazioni dello studente;
— Language in Literature (progetto nato negli anni ’80) e poi Views of Literature (1993), di Barbara De Luca, Umberta Grillo, Paola Pace, Silvana Ranzoli, un corso di letteratura che costituisce la più valida guida alla lettura dei testi letterari in lingua inglese; si sviluppa inoltre l’analisi dei generi letterari, visti in una prospettiva di svolgimento storico, attraverso l’ausilio di strumenti metodologici rigorosi; il carattere innovativo di quest’opera ne determina il successo, aprendo la strada ai successivi Literature and Beyond (1999) e Books and Bookmarks (2002) con l’ingresso nel gruppo degli autori di Deborah Ellis;
— la collana “Letteratura inglese e americana” (partita già alla fine degli anni ’80): si tratta di guide alla lettura che offrono una risposta operativa originale alle esigenze della scuola di far acquisire abilità di lettura e strumenti teorici di analisi.
Per il FRANCESE, i corsi di maggior successo sono La maison des lilas (prima edizione nel 1994; seconda edizione nel 1998) e successivamente Mots de passe(2004) e la versione ridotta Un autre Mots de Passe (2005) di Maria Lorenza Congedo e Madeleine Léonard.
Di grande fortuna è anche la produzione di titoli per l’insegnamento del TEDESCO: Deutschstunde (prima edizione nel 1992; seconda edizione nel 1998), diGabriella Montali, Alessandra Dughiero, Daniela Mandelli, Giorgio Motta e Hedi Weiβgerber; ABC Deutsch (2002) di G. Montali, D. Mandelli e H. Weiβgerber.
Nel 2004, escono due corsi, Direkt di Giorgio Motta per i Bienni, e Deutsch hautnah di Gabriella Montali, Daniela Mandelli e Nadja Czernohous Linzi per i Trienni.
Di Giorgio Motta non possiamo non ricordare il corso di tedesco per la scuola media Wir (1998, seguito da varie edizioni italiane) e il successivo Magnet (2007) che hanno visto diverse edizioni internazionali in collaborazione con la casa editrice Klett, tali da portare questo testo ad essere il più diffuso e tradotto corso di lingua tedesca nel mondo.
La Loescher entra poi con successo anche nell’area dello SPAGNOLO, in particolare con la letteratura Escenarios abiertos (2003), i corsi NosOtros (2006) e Muy rico (2009) tutti di Susana Benavente Ferrera e Gloria Boscaini.
Il settore lessicografico ha conosciuto grande vitalità, sia attraverso la produzione di opere nuove, sia per il costante aggiornamento dell’IL Vocabolario della lingua latina(1966), che nel 1990 ha avuto una seconda edizione e nel 1996 una terza, corredata da un CD-ROM (novità assoluta per questo ambito) che offre un rapido e agevole accesso alle voci latine e rende possibile il reperimento di parti specifiche del testo. A partire dal 2000, è stata aggiunta un’agile Guida all’uso che costituisce un eserciziario autonomo sull’uso del vocabolario. Nel 2007 è poi uscita la quarta edizione, che prevede sostanziosi miglioramenti tra i quali la revisione completa di tutte le voci (ca 50.000) della parte latino-italiano, la traduzione integrale di tutti gli esempi, l’arricchimento di informazioni grammaticali e linguistiche.
Nel 1986 Loescher aveva acquisito il Novissimo Palazzi. Dizionario della lingua italiana di Ferdinando Palazzi, prestigiosa opera lessicografica apparsa per la prima volta nel 1939 per i tipi della casa editrice Ceschina e successivamente ceduta al Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.A. Nel 1992 è stata portata a termine la realizzazione del nuovo Palazzi-Folena,Dizionario della lingua italiana, un’impresa editoriale di grande impegno, condotta sotto la guida di Gianfranco Folena, con la collaborazione di specialisti quali Carla Marello (lessicografia), Diego Marconi (filosofia del linguaggio), Michele A. Cortelazzo (storia della lingua italiana). È il primo vocabolario che riporta una datazione per tutte le parole.
Nel 1993 è uscito il Dizionario dei sinonimi e contrari, di Aldo Gabrielli, che nel 2001 ha conosciuto una seconda edizione con CD-ROM.
Nel 1995 la casa editrice ha pubblicato anche il dizionario Italiano junior, a cura di Anna Cattana e Maria Teresa Nesci, destinato ai più giovani e ripubblicato in nuove edizioni nel 2003 e nel 2010.
Sempre nel 1995 la produzione lessicografica della Casa editrice si è arricchita di un’altra opera di altissimo rilievo: il GI Vocabolario della lingua greca. Greco-italiano, frutto di un lavoro che ha impegnato per sei anni un’équipe di trenta grecisti, diretti dal professor Franco Montanari. Per il suo alto valore scientifico, il dizionario si inserisce degnamente nel ristretto panorama internazionale dei grandi lessici greci e contemporaneamente guarda con occhio attento al mondo della scuola Superiore tenendo presenti le esigenze degli studenti. Giunto nel 2004 alla sua seconda edizione, il GI conta circa 140.000 voci, tratte dalla letteratura arcaica, classica, ellenistica, dai testi di età imperiale e tardoantica, dalle opere dei primi secoli del Cristianesimo, dalle testimonianze di papiri ed epigrafi. Il vocabolario è arricchito da una Guida all’uso e Lessico di base, che intende avvicinare progressivamente chi affronta per la prima volta lo studio del greco alla corretta consultazione del GI, e di un CD-ROM, per un accesso agevole ed efficace all’ampio corpus, che costituisce un primato mondiale.
Gli anni ’90 sono caratterizzati anche da un programma di acquisizioni e di ampliamento, dal punto di vista commerciale, dei titoli distribuiti che consentono alla Casa editrice di rafforzare la propria presenza nel settore scolastico italiano. Tale programma continua anche per tutti gli anni ‘2000.
Nel 1993 Loescher Editore assorbe completamente la casa editrice Thema (di cui già deteneva una quota di partecipazione) ed Eliseo (1994); nel 1997 acquisisce la Marco Derva Editore di Napoli. È invece del 1998 l’acquisizione della distribuzione dei prodotti della prestigiosa Casa editrice G. D’Anna di Firenze (nel corso degli anni è cresciuta la quota di partecipazione in questa casa editrice fino a raggiungerne il controllo diretto nel 2009).
Intanto inizia anche l’attività di distribuzione in Italia del settore dei libri per l’insegnamento delle lingue moderne di importanti editori stranieri come l’inglese Cambridge University Press (a partire dal 1993), la tedesca Klett (dal 1997). A queste vanno aggiunte le francesi Nathan (dal 2000 fino al 2008) e CLE International (dal 2008), la danese Ashehoug Dansk Forlag (dal 2001) con la collana Easy Readers (per i testi di narrativa in inglese, francese, spagnolo e tedesco), più recentemente l’austriaca Helbling Languages (dal 2009, per testi di inglese) e la spagnola enClave-ELE (dal 2009).
Nel 2002 Loescher acquisisce il ramo d’azienda comprendente le edizioni scolastiche pubblicate con il marchio Jackson Libri del Gruppo Editoriale Futura e dal 2004 cura la promozione e la distribuzione dei libri diMandese Editore oltre che di Alfa Edizioni (già dal 1999).